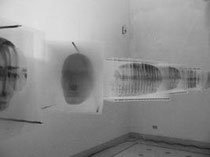«I Tentolini - dice - hanno un ramo agricolo e quello borghese. Il ponte ferroviario di Casalmaggiore è stato progettato da un Tentolini. Faccio parte del ceppo agricolo. Questa casa è stata acquistata da mio bisnonno negli anni venti. Il trisnonno Cipriano era protestante, la bisnonna ha introdotto l’educazione cattolica, un cugino è rimasto protestante». Il suo ordine etico - quello per la vita quotidiana e quello per il lavoro artistico - si regge sulle cadenze e le virtù di un’ampia famiglia comunitaria. Piera e Carlo i genitori. Ada e Maria le sorelle. Un fratello, Riccardo, oggi assente. Ada - tre bambini - gestisce un’enorme selleria (nella Bassa vanno a cavallo) con centinaia di selle americane, inglesi, messicane, scansie di stivali, speroni, finimenti, cappelli, fruste, frustini. Maria - angelica - nella foto abbraccia un grande tacchino di terracotta ricordo degli esercizi scolastici di scultura. La famiglia organizza un’impresa differenziata - asparagi, altre verdure e allevamento di cavalli, selleria per Ada e studio grafico di Giorgio e Maria. A tavola, dove si celebra la giornata del ‘ceppo agricolo’ di una gens tra tradizione e futuro, i Tentolini parlano. Raccontano di “gamberi killer che mangiano le rane e i girini” e forse vengono dai ristoranti cinesi; di nutrie, il ‘castorino selvatico’, “venute dall’est, allevate qui da noi per le pellicce, poi, a mercato saturo, liberate dalle gabbie”; di gazze e di corvi “dove ci sono le gazze i corvi non ci sono”. Le nutrie adesso, incessanti, perforano argini e sponde delle condotte d’acqua, tane larghe un metro e i trattori sprofondano nella mutazione geologica che la mutazione della fauna induce. La volpe poi, incursioni e stragi di ovaiole, i galletti no perché dormono in alto. Un universo animato, strisciato di inquietudini, e un giovane artista che da sempre - dall’inizio - fotografa e racconta a modo suo la fine di un mondo e sconosciuti in cammino in un divenire incognito.
Mia nonna paterna Ada Pelizzoni lavorava nella stalla, lavorava nei campi e nel tempo libero dipingeva, lavorava al ricamo e all’uncinetto, aveva questi aspetti creativi. Mi raccontava della campagna di quando lei era ragazza. Lavorava la canapa, la raccoglieva nelle lanche e la lasciava macerare. Lei è una delle persone con cui ho parlato di più in vita mia. Da lei e dai miei genitori - mio padre è agronomo, mia madre sarta da giovane e poi casalinga – mi viene il senso del lavoro, della ciclicità del lavoro, la fatica legata alla ciclicità. Ho sempre lavorato nei campi, lavorare nei campi dà un metodo, il dover concludere per forza, secondo delle tempistiche naturali, dover finire a tutti i costi con sforzi enormi i lavori in determinati momenti e poi il riposo. Le cadenze date da pressioni esterne. Quando ho abitato in città, a Londra, a Milano, ho provato dolore per l’assenza della natura. C’erano tantissimi alberi qui, c’era vita qui quando andavo bambino nelle campagne, adesso ci sono le coltivazioni intensive. Sono cose che mi danno sofferenza. Mi sento parte della natura, faccio parte del posto dove abito, sento di appartenere al posto dove sono, sento di abitarlo, ne vivo le giornate di sole come quelle di gelo».